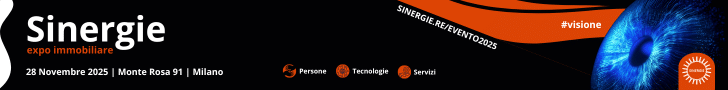In una Italia che invecchia, per gli over 65 esistono diverse soluzioni abitative che variano in base al livello di autosufficienza: dalla casa di proprietà o in affitto, al senior housing, agli appartamenti per anziani o case albergo, fino agli appartamenti protetti e alle RSA per chi non è più autosufficiente.
Nonostante queste possibilità, una quota crescente di famiglie scivola verso condizioni di disagio economico, complici la modesta crescita del Paese e l’aumento della povertà assoluta, che anche per gli over 65 è passata dal 5,1% nel 2014 al 6,2% nel 2023. Ciò rende sempre più urgente un’offerta abitativa accessibile, come social housing ed edilizia residenziale pubblica, affiancata a incentivi statali che oggi risultano però limitati da vincoli stringenti su reddito e massimali, escludendo così gran parte della cosiddetta “fascia grigia” della popolazione.
Queste sono solo alcune delle considerazioni che emergono dal nuovo report “Silver economy, trend e prospettive. Le diverse forme di residenzialità per gli Over 65” redatto da Research & data Intelligence di Patrigest, società del gruppo Gabetti specializzata in research, advisory e valuation.
Secondo Luca Dondi dall’Orologio, amministratore delegato di Patrigest (Gruppo Gabetti): “La carenza di offerta qualificata – soprattutto in strutture intermedie tra la casa tradizionale e la RSA – apre spazi per sviluppare prodotti innovativi, capaci di rispondere alle esigenze di benessere, sicurezza e socialità degli anziani. In un contesto di crescente attenzione al social impact, investire nel senior housing significa anche contribuire a una trasformazione positiva della società, favorendo inclusione e qualità della vita per le generazioni più longeve. Chi investe oggi nel senior housing, semina valore per il futuro e si prepara a raccogliere frutti solidi in termini economici e sociali”.
Sul fronte demografico, il mondo invecchia: entro il 2054 gli over 65 saranno più del doppio rispetto al 2024. Attualmente rappresentano il 10,2% della popolazione mondiale, con le quote più alte in Europa e Nord America. L’Italia è quarta al mondo per aspettativa di vita e prima in Europa per crescita della speranza di vita in buona salute a 65 anni (+42% in dieci anni, pari a 10,8 anni), anche se i paesi nordici superano i 14 anni.
L’Italia ha la più alta quota di anziani in Europa (24,3% della popolazione, contro il 21,6% medio UE), ma spende molto meno per assistenza sanitaria pro capite (303,9 € contro 607 €) ed è prima in Europa per peso delle pensioni sul PIL.
Sul fronte dei servizi, il Paese è indietro nei posti letto in Rsa: 512 ogni 100.000 abitanti, contro gli oltre 1.100 in Svezia, Germania e Finlandia, e sotto la media UE (699).
L’Italia affronta un vero inverno demografico: la popolazione, in calo dal 2015, scenderà a 45,8 milioni entro il 2080 (-22,6% rispetto al 2021).
Anche la spesa pubblica sanitaria sul Pil resta sotto la media UE (6,52% contro il 10,79% della Germania e il 10,01% della Francia). Dopo il forte incremento registrato negli anni 2020 e 2021, si è tornati ai livelli pre-Covid.
L’Italia avrà una popolazione sempre più anziana. Dal 1970 al 2080, assisteremo a una inversione di rotta: dalla prevalenza di popolazione giovane negli anni ’70, a quella dei boomers del 2025, per arrivare ad una generazione di anziani nel 2080.
L’indice di dipendenza anziani (ovvero quanti individui anziani – 65 anni e più – ci sono ogni 100 persone in età lavorativa,15-64 anni) si stima che passerà dal 39,8% nel 2026 al 66,8% nel 2080, con gravi rischi per la sostenibilità del sistema pensionistico.
Oggi ci sono 16,3 milioni di pensionati (pensione lorda media: 1.861 € al mese), con un rapporto 1,47 lavoratori per pensionato. La spesa pensionistica raggiungerà un picco nel 2040 (17,1% del PIL) per poi calare al 14% entro il 2070.
A seconda del livello di autosufficienza degli over 65, è possibile identificare 5 forme di residenzialità, ognuna con le proprie caratteristiche e target. A partire dall’abitazione propria, in proprietà o in affitto, fino ad arrivare alle RSA in caso di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, passando per il senior housing, gli appartamenti per anziani o case albergo e gli appartamenti protetti.
“Se è vero che le soluzioni esistono, sebbene non tutte oggi ugualmente diffuse, un elemento che le tendenze recenti confermano con chiarezza è il progressivo spostamento di una quota sempre più ampia di famiglie in condizioni di disagio economico. Anche se su questo versante, rispetto a quello demografico, l’incertezza è senz’altro più accentuata, l’eventualità di un’inversione di tendenza appare piuttosto remota, soprattutto perché la crescita del Paese si prospetta debole. Questo impone il ricorso a misure di sostegno più decise di quelle finora messe in campo, iniziative strutturali che allentino la pressione sui bilanci familiari. In questo disegno, il ruolo della componente immobiliare risulta cruciale, rappresentando una delle voci di costo delle economie domestiche con incidenza più elevata” sostiene Dondi Dall’Orologio.
Nonostante gli over 65 risultino più resilienti rispetto al totale della popolazione, negli ultimi anni una fetta maggiore risulta rientrare nella povertà assoluta, 6,2% nel 2023 rispetto al 5,1% del 2014, rendendo necessaria un’offerta di residenzialità accessibile, in Social Housing, ERS (edilizia residenziale sociale) o ERP (edilizia residenziale pubblica).
Oggi sono diversi gli incentivi statali a supporto della vecchiaia, ma si evidenziano limiti molto stringenti in termini di soggetti che ne hanno diritto, reddito, o massimali di copertura della spesa, di fatto escludendo la così detta “fascia grigia della popolazione”, negli ultimi anni al centro di dibattiti fra operatori privati e pubbliche amministrazioni.
Una ricerca edita da Wikicasa sugli over 65 mostra una netta preferenza per la proprietà, con il 75% delle richieste orientate all’acquisto (contro una media del 62%). La tipologia più cercata è il trilocale (34% delle ricerche), con una superficie media di 89 mq, inferiore alla media generale di 97 mq: segno di un ridimensionamento abitativo, per esigenze più contenute e una gestione domestica semplificata. Tra i criteri più importanti emergono il piano basso e l’assenza di barriere architettoniche, mentre l’efficienza energetica risulta meno prioritaria rispetto alle generazioni più giovani.
Parallelamente cresce l’importanza dei servizi di assistenza domiciliare: dal 2017 gli anziani seguiti dall’Assistenza Domiciliare Integrata sono aumentati del 58,3%. L’ADI consente di ricevere cure mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali a casa, riducendo ricoveri ospedalieri e favorendo il recupero in un ambiente familiare, con costi inferiori rispetto alle strutture residenziali.
Un’alternativa è rappresentata dai trattamenti semiresidenziali, offerti dai centri diurni soprattutto in Centro e Nord Italia. Questi servizi, rivolti ad anziani non autosufficienti o parzialmente tali, offrono assistenza sanitaria e sociale durante il giorno, permettendo però il rientro a casa la sera. Oltre a supportare gli anziani, alleggeriscono il carico quotidiano dei caregiver, rappresentando una soluzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e il ricovero in RSA.
In Italia il numero di anziani residenti nelle Rsa è in forte aumento, con una crescita del +36,5% dal 2017, accelerata dopo la pandemia e il conseguente aumento della non autosufficienza. Nel 2023 le percentuali più alte si registrano nel Nord-est (Trentino-Alto Adige e Veneto), seguite dal Nord-ovest (Piemonte e Lombardia), mentre il Mezzogiorno rimane molto indietro, con tassi di assistenza residenziale bassissimi in regioni come Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia.
Anche l’offerta di posti letto riflette il divario territoriale: al 2022 si contano 12.363 presidi residenziali per circa 408.000 posti letto, ma con un rapporto sulla popolazione nettamente più alto nel Nord-est, con valori fino a tre o quattro volte superiori a quelli del Sud.
Dal punto di vista giuridico, quasi il 78% dei posti letto è in mano a enti privati (con il 45% gestiti dal non-profit), mentre solo il 22,5% è pubblico. Lombardia e Piemonte primeggiano per posti letto privati. In tutte le regioni, la maggioranza delle strutture riceve comunque finanziamenti pubblici, con eccezione di Lazio e Molise.
Guardando al futuro, l’offerta di Rsa appare già oggi insufficiente: la maggior parte delle regioni non raggiunge il parametro di 50 posti letto ogni 1.000 over 65. Le proiezioni al 2050 mostrano un ulteriore peggioramento, con deficit particolarmente gravi in regioni come Lombardia, Lazio e Campania. Saranno quindi necessari significativi investimenti per rispondere all’invecchiamento della popolazione e alla crescente domanda di assistenza residenziale.
Il senior housing è un modello residenziale pensato per gli over 65 autosufficienti e nato in Nord Europa a fine anni ’60. Attualmente è una forma diffusa negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Germania e Scandinavia grazie anche ad agevolazioni fiscali. È un modello integrato all’insegna di qualità, sicurezza e comfort:
- Alloggi indipendenti moderni, facilmente accessibili e funzionali
- Servizi comuni e aree ricreative
- Opportunità di socializzazione
- Prossimità o accesso facilitato a strutture ospedaliere o ambulatoriali
- Possibilità di offerta di servizi alla persona su base individuale
- Non sono case di riposo, RSA o case di cura
In Italia 12 iniziative d senior housing attive
Il senior housing in Italia è ancora agli inizi: attualmente si contano 12 iniziative attive per un totale di circa 490 appartamenti (media di 41 unità ciascuna), un’offerta molto ridotta rispetto ad altri Paesi europei. La pipeline di sviluppo prevede 8 nuovi progetti, concentrati soprattutto al Nord, con oltre 1.000 appartamenti in arrivo, più del doppio dello stock attuale. I nuovi interventi saranno di dimensioni maggiori (circa 200 unità per progetto) e avranno come principali poli di sviluppo Milano, Roma e Torino. In particolare, Milano ospiterà il più grande progetto italiano, con circa 360 appartamenti, mentre a Roma è prevista una riqualificazione che porterà 300 nuove unità.
Dal punto di vista territoriale, l’offerta è fortemente sbilanciata: il sud è del tutto assente, mentre Nord e Centro concentrano quasi tutte le strutture esistenti e future. Gli appartamenti sono perlopiù bilocali di 38-55 mq, affiancati da alcune soluzioni mono e trilocali, realizzati con standard energetici elevati e in certi casi dotati di domotica.
Sul piano contrattuale prevalgono le formule di locazione a lungo termine (4+4 e 3+2), ma cresce l’interesse per gli affitti brevi, utili per esigenze temporanee e come leva di marketing turistico. Catastalmente, la maggior parte delle soluzioni è classificata come abitazioni civili (74%), mentre una parte risulta classificata come case di cura (22%).
I canoni includono, nella maggior parte dei casi, bollette e wifi, pulizie, manutenzione, servizio di concierge h24, e uso degli spazi comuni, quali aree fitness e wellness, piscine, parcheggi, aree esterne, mentre restano opzionali servizi aggiuntivi come la lavanderia, servizi di mobilità, ristorazione e alcune attività di intrattenimento.
In Europa nell’H1 4,4, mld di investimenti in healthcare in Europa
Nel primo semestre del 2025 gli investimenti europei nel settore Healthcare hanno raggiunto 4,4 miliardi di euro, segnando un +51% rispetto al 2024. La crescita riflette il ritorno di fiducia degli investitori, sostenuta dall’aumento delle tariffe sanitarie, da oneri finanziari più bassi e da migliori performance degli operatori. I mercati leader restano Regno Unito e Germania, seguiti da Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia.
In Italia, dopo un 2024 debole, gli investimenti Healthcare hanno toccato circa 270 milioni di euro già nel primo semestre 2025, superando l’intero volume dell’anno precedente. Dal 2019 a oggi, il 50% degli investimenti si è concentrato al nord, e il 37% su portafogli, mentre il 91% ha riguardato strutture operative, e solo il 9% progetti di sviluppo.
Il senior housing resta un comparto marginale in Italia, con investitori che solo recentemente iniziano a esplorarlo. Le difficoltà derivano da barriere culturali (gli over 65 italiani sono restii a lasciare la propria casa) e da ostacoli economici. L’88% degli investimenti riguarda infatti progetti di sviluppo, vista la scarsità di offerta già attiva.
Negli Stati Uniti, invece, il modello è consolidato, in particolare in Florida, che è il terzo stato per numero di iniziative dopo Texas e California. Qui, il 40% della popolazione ha più di 50 anni, attratta non solo dal clima, ma anche dall’assenza di tassazione sui redditi e dall’ampia offerta di soluzioni abitative per senior. Questo flusso di immigrazione interna è sostenuto da due importanti fattori: dall’alta percentuale di popolazione in affitto (il 35% nel 2025) e dall’assenza di barriere linguistiche.
In conclusione, il futuro delle soluzioni abitative per gli over 65 rappresenta una sfida cruciale per il sistema sociale italiano, soprattutto alla luce della crescente incidenza della popolazione anziana e delle nuove esigenze legate alla longevità. È fondamentale che istituzioni, imprese e cittadini collaborino per sviluppare modelli di senior housing innovativi, sostenibili e inclusivi, capaci di garantire benessere, sicurezza e accessibilità a tutti gli anziani, anche a coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica. Solo un approccio integrato tra politiche abitative, servizi assistenziali e supporto economico potrà rispondere efficacemente alle trasformazioni demografiche in atto, costruendo un futuro più giusto e dignitoso per le generazioni senior.
“Dal punto di vista degli investitori, il settore del senior housing rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e diversificazione. L’invecchiamento della popolazione italiana, con una quota di over 65 in costante aumento e una domanda sempre più sofisticata di soluzioni abitative, genera un mercato in espansione e ancora poco presidiato rispetto ad altri Paesi europei.” conclude Dondi.