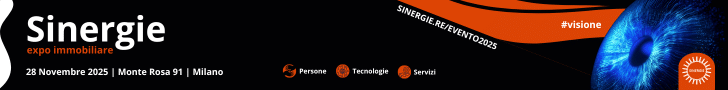Ci sono tante cose, nella vita, che diamo per scontate.
In Italia, per esempio, ognuno di noi è a meno di un’ora di viaggio da almeno uno dei 59 siti UNESCO sul territorio, patrimoni mondiali dell’umanità.
Diamo per scontato anche che, per la maggior parte di noi, accedere a questi luoghi sia facile. Facile come guardare un’opera d’arte, ammirarla, capirla.
Dobbiamo però ricordarci che non è così. Che anche solo il concetto di vicinanza a un luogo di bellezza, artistica o naturale, è un privilegio.
Che anche solo vedere è un privilegio.
Questa è la storia di tre persone che hanno fatto di questi concetti il vero e proprio cuore della loro iniziativa.
Tre persone che dal profondo di una bellissima provincia del sud della Puglia, Lecce, stanno costruendo, con curiosità e competenze, un nuovo modo di fruire dell’arte.
Si tratta di Paola Zamperlini, Arialdo Zamperlini e Mattia Moretto, il team operativo, nonché fondatore di HEART, nato nel 2023.
Con un background multidisciplinare, tra Conservazione dei Beni Culturali e tecnologie 3D di scanning e fotogrammetria, hanno sviluppato e brevettato una metodologia che consente la riproduzione in tre dimensioni di opere d’arte – dipinti o statue – che vengono messe a disposizione dei visitatori, per un’esperienza tattile accessibile anche e soprattutto a persone non vedenti, ovvero cieche o ipovedenti.
ML: Ciao Paola, il mondo per te è…?
PZ: Io sono un’appassionata di arte, per cui direi… esplorare e scoprire la cultura.
In Italia siamo molto fortunati: siamo circondati dalla bellezza!
ML: Ci racconti come è nato HEART?
PZ: Tutto è partito per puro caso.
Io frequento spesso ambiti museali. Un giorno ero in visita a un museo. Generalmente nei musei vige un certo silenzio – una regola, scritta o non scritta, che ci invita a concentrarci e ad ammirare le opere d’arte esposte. Quel giorno, invece, una coppia attirò la mia attenzione, perché la ragazza stava descrivendo, ad alta voce e in modo minuzioso ogni dettaglio presente sul dipinto che aveva dinnanzi. Lo stava facendo, rompendo il silenzio museale, perché il ragazzo che la accompagnava era non vedente. Questo approccio di fruizione mi ha emozionato molto e mi ha dato la voglia di concretizzare il progetto HEART, che allora era solo agli albori.
Pochi mesi dopo questo episodio, siamo stati contattati da un restauratore salentino. Una statua di un santo era stata danneggiata da un fulmine: l’aureola era caduta a terra e si era frantumata a terra in mille pezzi.
Io, Arialdo e Mattia, con la nostra società Spe3D SRL, ci occupiamo di rilievi e fotogrammetria 3D, sia per edifici che per manufatti. Collaborando con il restauratore, abbiamo eseguito una serie di scansioni 3D dei pezzi dell’aureola infranta e li abbiamo ricreati, riassemblati digitalmente in un software, come in un puzzle, e dunque ricostruiti.
A distanza di poche settimane, queste due esperienze ci hanno fatto rendere conto che il progetto HEART era realizzabile, che avevamo sia la missione che le competenze. E siamo andati avanti.
Non è stato facile, perché all’inizio di ogni cosa c’è sempre un po’ di diffidenza – specialmente nell’ambito culturale, quando si parla di tradizione e conservazione. Ma noi ribadiamo che non andiamo a copiare opere d’arte, bensì a riprodurle con altre metodologie.
E poi è vero che manca ancora qualcosa, nella fruizione museale, per le persone cieche o ipovedenti: non basta semplicemente ascoltare una descrizione, per quanto dettagliata o narrativa, benché possa essere un approccio molto emozionante. I non vedenti hanno voglia di vivere l’esperienza museale come tutti quanti.
ML: Mi puoi guidare nel processo di riproduzione ed esposizione di un’opera?
PZ: Abbiamo effettuato un “restauro digitale” di un dettaglio della facciata della Basilica di Santa Croce a Lecce, uno degli esempi più emblematici del barocco leccese.
Al primo colpo d’occhio, davanti a questa magnifica basilica, tutti guardano il bellissimo rosone, al quale tutte le linee prospettiche della facciata convergono. Ma il centro esatto si trova poco più in basso, un dettaglio che anche ai più esperti sfugge, ma che è di notevole importanza. Si tratta di una nicchia in cui c’è la statua della Vergine del Rosario, realizzata in pietra leccese e che si è andata a deteriorare nel corso del tempo.
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di reimmaginare le forme che si sono andate a perdere nel tempo. Abbiamo utilizzato un drone per effettuare una fotogrammetria, una tecnica scientifica che permette di ottenere misurazioni, forme, posizioni in 3D di oggetti attraverso una serie di fotografie scattate da diverse angolazioni. Abbiamo dunque creato il primo modello digitale.
Un vero e proprio restauro ricostruttivo. Il lavoro preliminare di ricerca storica è stato importante, per capire i dettagli iconografici di questa Vergine. Siamo andati a ricostruire le forme, basandoci su ipotesi di quelle che avevano potuto essere prima che l’azione del tempo e dei fattori atmosferici deteriorasse la pietra leccese. Abbiamo ripreso l’elemento della corona della Vergine, che nell’originale vediamo solo abbozzata, e anche un elemento della corona del Rosario, tenuta in mano da Gesù bambino in braccio alla Madonna, ma che in realtà ormai non si vede più, e così via.
L’abbiamo quindi stampata in tre dimensioni, e montata su un supporto, su cui è presente un tag NFC, che, attraverso gli smartphone, consente di riprodurre una traccia audio descrittiva.
La didascalia delle opere con carattere in Braille ha, accanto, caratteri in rilievo con colori di contrasto – generalmente sfondo nero e carattere in bianco – per aiutare le persone ipovedenti a individuare titolo dell’opera e autore.
Quando abbiamo esposto la Vergine del Rosario al pubblico, a maggio 2025, abbiamo pensato a un percorso in cui le persone avevano accesso alla riproduzione all’interno di una stanza immersiva: potevano toccare e ascoltare un racconto coinvolgente che descriveva l’opera e la sua riscoperta.
La cosa bella è che a seguito della visita, molte persone ci hanno mandato foto su foto della facciata della Basilica di Santa Croce, scrivendoci che avevano finalmente notato il dettaglio della nicchia della Vergine del Rosario e che era stato bellissimo poter toccare e conoscere un’opera d’arte che fisicamente non era accessibile.
ML: Ci puoi descrivere come HEART intende l’accessibilità?
PZ: Il nostro obiettivo è aprire le porte dell’arte a tutti.
In Italia non siamo i primi a sostenere questo tipo di approccio tattile. Ciò che ci distingue è l’offerta di un percorso completo, personalizzato ed economicamente sostenibile, capace di adattarsi alle esigenze dei diversi pubblici.
Durante i mesi di ideazione e definizione del progetto, ci siamo confrontati con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce. È stato un dialogo continuo, con persone cieche e ipovedenti. Loro ci hanno espresso il desiderio di vivere l’esperienza museale come tutti. Hanno voglia di entrare in un museo, di effettuare il percorso e di trovare, sul percorso, delle opere tattili. Non vogliono l’intero museo tattile, perché sarebbe una fruizione troppo impegnativa.
Li abbiamo quindi ascoltati, e abbiamo lavorato insieme.
ML:
Quanto la tecnologia è entrata nella vostra fase di ricerca?
PZ: Tantissimo. Un esempio è la ricerca del materiale con cui sono poi stampate le riproduzioni 3D: abbiamo fatto varie prove e ricevuto vari riscontri dalle associazioni di persone non vedenti, affinché trovassimo una superficie solida, duratura, ma piacevole al tatto.
Un altro esempio: per l’avvio della traccia audio descrittiva, non abbiamo scelto un QR code perché hanno difficoltà a inquadrarlo. Una cosa che abbiamo notato è che quasi tutte le persone cieche e ipovedenti scelgono un iPhone, perché è uno smartphone che ha già preinstallate e attivate delle impostazioni che permettono di individuare e leggere i tag NFC.
ML: Hai detto più volte che HEART è un progetto che vuole avvicinare l’arte a tutti…
PZ: Noi inizialmente parlavamo di HEART come un progetto di accessibilità culturale, rivolta a persone con disabilità visive e motorie.
Dopo averlo presentato al pubblico, abbiamo capito che noi vogliamo parlare di accessibilità, ma con un approccio trasversale.
Ci riferiamo, per esempio, ai bambini, ai ragazzi adolescenti – che sono lontani, lontanissimi da questo mondo – ma anche a persone più grandi che magari non sono interessate al mondo dell’arte. Con questo tipo di interazione si può avere un contatto effettivo con una riproduzione dell’opera, che riesce a far esperire al fruitore un approccio diverso, attraverso sensi che solitamente non impieghiamo quando ci avviciniamo a opere d’arte figurativa – pittura o scultura che sia. Vogliamo creare un rapporto vivo, tra l’opera d’arte e il visitatore.
ML: Com’è arrivata questa intuizione?
PZ: Quando abbiamo presentato HEART al pubblico, a maggio 2025, nel contesto della manifestazione “Cortili aperti”, promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Puglia, abbiamo avuto circa 1000 visitatori. Abbiamo chiesto loro di compilare dei questionari di feedback.
Una buona parte è stata di visitatori tra studenti e studentesse di scuole elementari e medie, tra i 5 e i 13 anni. Sono state le risposte più belle.
Quando questi bambini entravano nello spazio espositivo e vedevano le nostre riproduzioni 3D erano un po’ titubanti: potevano toccare o no? Perché erano stati abituati – ed educati – a non toccare niente nei musei, a stare zitti, a guardare e basta.
Vedere bambini di 8, 9 anni toccare ogni dettaglio, soffermarsi sulle forme dei personaggi rappresentati, essere coinvolti nella fruizione, è stato bellissimo.
Altro discorso è per i ragazzi un po’ più grandi, gli adolescenti. Io ho un fratello di 18 anni che non ama i musei: per lui tutto ciò che è arte è noioso. Abbiamo fatto una presentazione anche in una scuola superiore. Alla semplice domanda: “quanti di voi sono stati in un museo di propria iniziativa?”, nessuno ha alzato la mano. Purtroppo, questa è la realtà di oggi.
Tuttavia, alla fine della mattinata, tutti i ragazzi e le ragazze di questa classe superiore hanno voluto fare l’esplorazione tattile.
Questo ci ha fatto capire che le nuove generazioni hanno bisogno di un approccio diverso nell’avvicinarsi al mondo culturale, hanno bisogno di sentirsi protagonisti della visita. Che non sia solo una visita passiva – guardare, leggere, ascoltare è importante – ma che si creino anche delle interazioni tra l’opera e il soggetto.
ML: C’è stata curiosità o sostegno da parte delle istituzioni pubbliche e private?
PZ: È stato possibile realizzare parte del nostro evento di presentazione di HEART grazie al patrocinio del comune di Lecce, della provincia di Lecce, del Garante della regione Puglia per i diritti delle persone con disabilità, così come è stato fondamentale il sostegno di cooperative sociali di promozione culturale sul territorio, come Artwork, che ci ha ospitati nei loro spazi espositivi.
ML: Per il futuro di HEART, che cosa desiderate?
PZ: Il nostro desiderio è quello di far conoscere il più possibile il nostro progetto, anche al di fuori del territorio salentino. Abbiamo già diversi contatti in diverse regioni d’Italia. Ogni incontro può essere spunto di qualcosa di nuovo, un confronto in più, un’idea reciproca. Speriamo di poter collaborare con altre realtà museali. E di continuare a lavorare su più fronti, non ultimo il ripensare alla fruizione culturale per le fasce anagrafiche più basse, bambini e adolescenti, perché possano appassionarsi d’arte e bellezza in un modo nuovo.
Prima o poi tutte le realtà dovranno fare un passo verso la cultura dell’accessibilità. E noi speriamo che questo succeda presto, sia a livello territoriale che regionale, sia nel privato che nel pubblico.