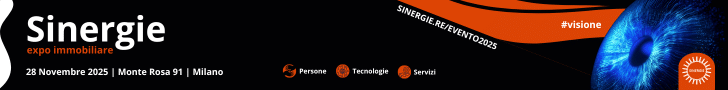L’architetta e filosofa Sarah Robinson sottolinea la portata culturale del cibo. L’atto del mangiare è molto più che un fatto biologico, mette in atto una catena di conseguenze che interessano tutti gli ambiti della nostra vita sociale: pratiche agricole e lavorative, condivisione e legami, modelli di ospitalità e rapporto con il divino nelle diverse culture, sapere in senso lato (“la degustazione è il modo principale in cui arriviamo a conoscere il mondo”).
Robinson introduce una prima dimensione progettuale: se è vero che l’ambientazione determina il gesto, l’architetto, il progettista, può contribuire alla trasformazione del nostro rapporto con il cibo rinforzando le connotazioni qualitative della domesticità (e non solo) e accompagnare attivamente il passaggio dalla funzione elementare quantitativa a una pratica atmosferica che investa anche la relazione tra città e paesaggio.
Tuttavia il problema è a scala globale e ha forti sedimentazioni storiche.
Alberto Giuntoli, architetto paesaggista e professore all’Università di Firenze, fa un excursus sulle modificazioni del paesaggio agrario italiano ricordando come da secoli sia stato plasmato dall’attività umana, tanto da chiedersi quanto la campagna sia mai stata davvero il luogo della natura.
Certo lo è stata in misura maggiore fino all’avvento della meccanizzazione e dell’efficientamento della produzione agricola, che hanno portato alle monocolture intensive e alla perdita di biodiversità (oltre che di valori paesaggistici). Oggi non è rimasto quasi più nulla che non sia intaccato dall’uomo, tanto che la dicotomia metropoli-campagna fatica a mantenere un pieno significato (la mostra Countryside di OMA ne è la registrazione).
Allo stesso tempo, c’è da chiedersi se la città stessa sia ancora il luogo per l’uomo.
Oggi la città occupa oltre il 50% della popolazione umana in conurbazioni paradossali (c’è stato un incremento di urbanizzazione del 78% a fronte di una crescita di popolazione del 33%).
Quali sono i suoi margini?
Un elemento di frontiera su cui vale la pena investigare sono proprio quei confini irregolari delle aree urbanizzate, detti ecotoni, che hanno un carattere ibrido tra artificio e natura, ma che sono tuttavia difficili da rendere produttivi e spesso diventano terreni incolti e abbandonati (e dove la soluzione è spesso l’edificazione e l’ulteriore consumo di suolo). La sfida è allora un approccio multifunzionale che sappia valorizzare non solo la produzione agricola ma un più ampio ventaglio di servizi ecosistemici, di tipo produttivo e culturale in senso lato, per restituire valore a luoghi altrimenti in difficoltà. Un approccio sperimentale di agricoltura urbana, come nel distretto di Sinqiao a Shanghai per esempio, che ha un crescente appeal ma di cui non è stata ancora dimostrata la sostenibilità, di fronte alla pressione demografica, come effettiva alternativa all’alterazione e distruzione del paesaggio naturale.