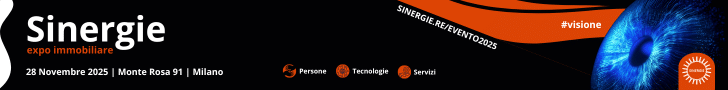Il nuovo spazio residenziale deve incrociare tutte queste dimensioni. Allo stesso tempo dovrà declinarle sui processi reali, sulle fattibilità economiche e i suoi ritorni, trovando un equilibrio tra esigenze di capitale, miglioramento sociale e sostenibilità ambientale.
Per questo è necessario costruire un nuovo processo interdisciplinare su una matrice di bisogni sovrapponibili:
• Gli End-User con esigenze di identità e lifestyle personale, adattabilità domestica, privacy, sicurezza e controllo, vitalità sociale e personale, accessibilità economica, ma anche nuovi spazi funzionali (magazzino, stoccaggio, leisure ecc.) e nuovi sistemi di arredo (si apre un mondo), nuovi equilibri tra flessibiltà e stabilità.
• I Developer con richieste di processi efficienti di sviluppo, opportunità commerciali, controllo dei costi di costruzione, ritorno degli investimenti.
• La sfera socio-politica con i temi di incremento demografico urbano, diversità sociale e culturale, anzianità, supporto alle famiglie, gap generazionali, sociali ed economici, diversità di genere, salvaguardia ambientale, tecnologia e digital divide, sicurezza pubblica, gentrificazione.
Armonizzare le diverse dimensioni tra loro e farle confluire in un campo comune di bisogni universali è l’obiettivo:
per un orizzonte di connettività urbana, efficienza energetica, edifici sostenibili, alloggi a prezzi accessibili, valori senza tempo, “a prova di futuro”, quartieri sicuri con facili relazioni di vicinato, spazi verdi e supporti demografici specifici.
<h2>Un rinnovato terreno comune
Quando nel 2010 Kazuyo Sejima chiamò People meet in architecture la sua Biennale d’architettura veneziana (prima donna a dirigerla), voleva esplicitamente riconsegnare all’architettura un ruolo fondamentale: quello di ineludibile catalizzatore di appartenenze collettive nell’uso dello spazio. Da allora questa ritrovata necessità d’indagine si è via via rafforzata.
Nel 2012 David Chipperfield scelse il tema Common Ground per focalizzarsi su ciò che considerava “il cuore dell’architettura”, e cioè una cultura “vitale e interconnessa che si interroghi sui territori condivisi, intellettuali e fisici, e favorisca la collaborazione e il dialogo”.
Yvonne Farrell e Shelley McNamara (Grafton Architects) hanno poi scelto il titolo Freespace nel 2018, focalizzando l’attenzione sulla libera potenzialità dello spazio come rappresentazione generosa del senso di umanità comunitario che l’architettura colloca al centro della propria agenda.
E infine oggi, la Biennale a cura di Hashim Sarkis propone il tema How will we live together?, e non poteva essere più adatto, nella sua forma interrogativa, in questo imponderabile 2020 che tutto trasforma in una grande incognita.
La domanda è quindi ancor più decisiva: Come vivremo insieme? Come dovremo progettare per “raccogliere” sotto il nostro habitat costruito nuove e vecchie comunità?