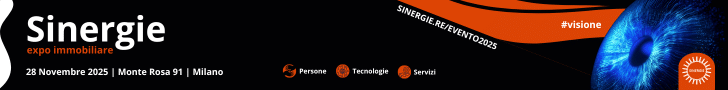In questa intervista ho capito che dietro una sigla o un acronimo non si nasconde solo una norma, uno standard, o una certificazione.
Ho capito che quelle lettere e numeri un po’ antipatici, che spostano l’immaginario della sostenibilità da un mondo di alberi e persone a un mondo di dati, sono lì per tutelare e dare valore alla bontà di un’azione spesa per la comunità, per l’ambiente, per l’azienda.
Me lo ha fatto capire Ida Schillaci, Senior Sustainability Advisor, che nell’auditing ha speso gran parte della sua carriera, lavorando per uno dei più grandi gruppi della GDO e per grandi marchi del retail, per poi diventare una consulente che progetta, monitora e supervisiona progetti di sostenibilità.
ML: Benvenuta a Redpoint_Real People, Ida!
Iniziamo con il nostro solito gioco! Com’è il mondo, per te… in tre parole?
IS: Inizio con “complesso” ed “evoluto”. Complesso proprio perché evoluto: tecnologicamente, scientificamente e umanamente. E poi, “interconnesso”, perché ogni volta che affronti il mondo, lo devi guardare da più punti di vista. Altrimenti, rischi di fare le scelte sbagliate. O per lo meno, giuste solo per una parte, ma non per il tutto.
ML: Come ti descriveresti, professionalmente, a chi non ti conosce? Cosa fa, Ida, chi è?
IS: Anch’io sono, nel mio piccolo, una persona complessa. Mi sono sempre occupata di tematiche ambientali, sin da bambina. Ero la piccola attivista che andava a pulire i parchi. Ho scelto studi che mi portassero in quella direzione: mi sono laureata come ingegnere ambientale. Nel mondo del lavoro ho iniziato come auditor all’interno di un ente di certificazione, facendo valutazioni secondo le norme ISO 9001, ISO14001, e la vecchia OHSAS18001 che adesso è diventata ISO 45001. Sono le tre norme cardine che riguardano qualità, ambiente e salute, e sicurezza sul lavoro.
ML: Se dovessi descrivere il tuo lavoro di auditor?
IS: L’auditor è una persona appartenente a un organismo indipendente, che visita i siti dell’azienda, consulta i documenti di rendicontazione, di processo, e a seconda della norma – qualità, ambiente o salute e sicurezza sul lavoro – alla fine delle giornate stila un rapporto in cui segna tutto quello che è conforme e tutto ciò che non è andato bene, ovvero le “non conformità” o “raccomandazioni e indicazioni per il miglioramento”. Ho svolto questo lavoro per quindici anni, fino a quando non mi si è aperta la possibilità all’interno di un’azienda, in quello che viene chiamato ufficio HSE – ovvero Health, Safety and Environment – e lì mi sono occupata direttamente di sostenibilità, con un bagaglio importante di tutte le normative, a livello italiano ed europeo.
ML: Quindi, con il tuo bagaglio, riesci a mettere a terra tutte le esigenze, le necessità di un’azienda, ma anche i sogni di sostenibilità che ti vengono proposti.
IS: Hai detto la parola giusta, “i sogni”. La sostenibilità, molti anni fa, aveva un non-so-che di sognante… all’inizio eravamo tutti sognatori: sognavamo di migliorare il nostro mondo, da un punto di vista ambientale e sociale. Adesso è molto diverso. L’approccio alla sostenibilità è cambiato tanto. Purtroppo.
ML: Da sognatori a…?
IS: …a rendicontatori. La sostenibilità oggi è numeri. Le norme ti impongono di rendicontare, in modo molto stringente. Li impone quella che è la CSRD. Impone documenti molto molto fitti, dove c’è poco spazio per il sognatore, per chi vuole effettivamente cambiare il mondo. In un mondo economico, bisogna sempre pensare che l’azienda deve fare profitto. Però c’è sempre quel margine, quella finestra per dire “io faccio profitto, ma con un business etico, e possibilmente raccontandolo.”
Sono riuscita a fare tante cose, quando mi hanno dato la possibilità di farle. E con budget neanche particolarmente esosi.
ML: Ci puoi fare un esempio?
IS: Ti porto un esempio di tipo sociale. Laura Bocchi, un’assessora del comune di Verona mi aveva inviato una richiesta di collaborazione per un progetto a cui teneva molto, e noi come tantissime attività commerciali – dal parrucchiere all’aeroporto – abbiamo risposto all’appello.
L’assessora è mamma di un bambino con spettro autistico e ci ha raccontato le difficoltà quotidiane che deve affrontare una famiglia. Dalla difficoltà di far tagliare i capelli al figlio, all’andare a fare la spesa o mangiare fuori al ristorante. Ci ha presentato un primario dell’ospedale di Verona e ci ha raccontato cosa potevamo fare, nel piccolo, per venire incontro a questi bisogni così speciali e così comuni al tempo stesso. Ho lavorato a questo progetto per un negozio della Grande Distribuzione. Il progetto è stato realizzato totalmente a costo zero. Non solo a costo zero, ci abbiamo pure risparmiato.
ML: Raccontaci!
IS: Ci è stato chiesto, per prima cosa, di dimmerare le luci del punto vendita, per ridurre l’intensità luminosa in alcune fasce orarie. L’abbiamo fatto, in quel negozio specifico, per tre giorni a settimana, in tre fasce giornaliere. C’era una fascia mattutina, una fascia a cavallo del pranzo e una fascia serale. Abbiamo pensato: le persone con spettro autistico e le loro famiglie potrebbero essere lavoratori: abbiamo quindi individuato le tre fasce orarie in modo da garantire la possibilità di accedere in negozio nei giorni della settimana in cui l’affluenza non sarebbe stata intensa.
Perché non l’abbiamo fatto tutto il giorno e soltanto in alcune fasce?
Perché altrimenti avremmo avuto problemi per gli ipovedenti.
Questo dimostra che dev’essere tutto bilanciato. Il mondo è complesso, ma se consideri l’uno, ti dimentichi dell’altro. E così via.
ML: Hai detto che avete risparmiato… come?
IS: Dimmerando la luce, abbiamo risparmiato un terzo del consumo energetico di quel negozio.
E abbiamo avuto la possibilità di accogliere delle persone dandogli uno spazio sereno.
L’unico investimento che abbiamo fatto è stato quello di formare le persone del negozio. Tutte, in ogni ruolo e in ogni ambito. Una formazione specifica che garantisse a queste persone con bisogni speciali che il personale di negozio sapesse gestire sia l’interazione sia un possibile momento di crisi durante l’esperienza all’interno dello spazio commerciale.
Facendo così, noi abbiamo reso quel negozio “autism-friendly” e abbiamo aderito a quel protocollo di Verona di cui parlavo, che aveva messo le basi per questa operatività.
ML: Mi sembra che ci sia, in questo approccio alla sostenibilità, una parte creativa, di ingegno.
IS: Sì, questa esperienza è stata creativa, ma molto complessa. Per esempio, riguardo al tema “sicurezza sul lavoro”, il negozio deve avere un minimo di luminosità per i lavoratori. Sono state fatte delle analisi, per riuscire a non scendere sotto determinati lux.
Questo dimostra che, in azienda, se per un progetto che riguarda la sostenibilità non si coinvolgono tutte le direzioni – direzione tecnica, salute sicurezza, direzione negozio, direzione vendite, direzione commerciale, ecc – qualsiasi sogno fallisce.
Per questo, la sostenibilità vive un mondo complesso e interconnesso. Abbiamo fatto un progetto sociale. Eppure, ha impattato su tutto il negozio e su tutte le direzioni.
Abbiamo studiato. Non ci siamo fermati, abbiamo creato dei kit informativi, di modo che i clienti con queste esigenze, entrando nel supermercato, potessero dirigersi senza timori e con più comodità da un reparto all’altro… da cosa nasce cosa, ci siamo sbizzarriti!
ML: E vi siete anche divertiti.
IS: Ecco, il ruolo di chi fa sostenibilità, per me, è questo. Non è raccogliere numeri. Chi fa sostenibilità deve avere quell’estro creativo di capire i bisogni del territorio in cui è. Quindi: se io sono un’azienda, impatto verso l’esterno, verso il territorio, ma devo anche capire che l’esterno impatta su di me, che io, come azienda, faccio parte di una comunità, con tutte le interconnessioni ambientali e sociali con quella che è la mia realtà. E da questo creo la mia governance.
ML: Quando hai incontrato il mondo dell’edilizia, nel tuo lavoro, di che cosa ti sei occupata?
IS: Per un periodo ho lavorato alla ristrutturazione di un negozio che passava da un brand all’altro. Cambiava tutto: cambiava la categoria merceologica, cambiavano le esigenze. Avevamo uno spazio grezzo e, con il team, abbiamo potuto valutare le scelte a meno impatto, dagli impianti agli arredi.
Pensiamo a una cosa banale come la questione, annosa nei centri commerciali, “porta aperta o porta chiusa”. È vero che avere una porta sempre aperta invita di più ad entrare, ma questo fatto, indipendentemente dalla stagione, porta a un incredibile consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento. Pensiamo a un altro esempio: gli sportelli del banco frigo nella GDO. Se gli sportelli sono aperti o inesistenti, il banco frigo dev’essere a una temperatura molto più bassa, perché gran parte della refrigerazione viene dispersa nell’ambiente. Col pericolo di congelare l’ultimo prodotto in fondo e sottoporre il primo prodotto più avanti a una temperatura più alta di ciò che dovrebbe essere. Oltre alla sostenibilità, il problema interconnesso, qui, è la qualità e la sicurezza del prodotto.
ML: Certificazioni, protocolli, normative… come orientarsi?
IS: Esistono tantissime normative ed esistono da un sacco di tempo. Sei dunque obbligata, come azienda, a fare determinate scelte. La Legge 10 è un insieme di norme che riguardano il contenimento dei consumi energetici negli edifici e la promozione dell’uso razionale dell’energia, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili. Pensa: è del 1991. Non è certo nuova!
Chi fa progettazione, conosce perfettamente questa legge, perché è uno dei presupposti del costruire.
Poi esistono tutta una serie di protocolli, come il LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), il BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), il Protocollo ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – Associazione nazionale delle Regioni e delle Province autonome) che è quello italiano, che nascono dalla volontà di creare qualcosa di volontario per aggiungere degli elementi. La legge 10 è obbligo. I protocolli che ho citato, invece, danno tutta una serie di indicatori, che poi sono certificabili, per raggiungere una determinata eccellenza.
ML: Tra i protocolli che hai elencato, solo uno è italiano.
IS: Nonostante sia italiano, il Protocollo ITACA è il meno utilizzato, forse perché il LEED e il BREEAM, che sono internazionali, sono di più facile comprensione per gli investitori esteri che mirano ad ottenere delle certificazioni. E queste certificazioni diventano vettori di business nel momento in cui chi investe vuole una garanzia di sostenibilità, che genera prestigio e valore nell’immobile.
ML: Dove possiamo ancora scegliere di essere sostenibili, quindi con un approccio più da sognatori che da data analyst?
IS: Nel mondo dell’edilizia, c’è un tema finanziario perché tutte le nuove opere, soprattutto se grandi opere, sono soggette alla Tassonomia. Come si può scegliere di diventare ancora più sostenibili – dopo aver fatto tutto ciò che è obbligatorio?
Io faccio sempre l’esempio di un negozio di Benetton, a Firenze, dove per allestire il punto vendita, dagli arredi ai materiali, sono stati utilizzati materiali di scarto della lavorazione tessile, facendo coincidere un discorso sul riciclo all’interno della loro linea produttiva, con la loro identità. Come questo, nel tempo anche altri brand importanti, come Yamamay a Siena e Venezia, hanno iniziato a creare i punti vendita con una maggiore attenzione.
C’è sempre un modo per essere sognatori.
ML: Che cosa, ancora, si fatica a capire sulle certificazioni?
IS: La certificazione è un ottimo modo per comunicare la sostenibilità perché è la garanzia che viene fornita da un ente terzo e indipendente, che ha verificato e firmato, ovvero si è preso la responsabilità che quello che ha misurato risponde ai criteri.
Sono dei guardiani, questi enti certificatori, contro i pericoli di green/pink/rainbow/ecc-washing. Cosa che non tutti sanno è che l’ente non è autoreferenziale: anch’esso è controllato a un altro ente di controllo nazionale, Accredia (Ente unico di accreditamento italiano), che verifica tutti gli enti di certificazione, campionandone le pratiche.
ML: In che modo la comunicazione della sostenibilità può essere un asset per la sostenibilità stessa? E quali sono ancora i passi in avanti da compiere?
IS: La comunicazione è fondamentale, ma non bisogna dimenticarsi di farlo, oltre che esternamente, anche internamente. È importante comunicare a colleghi e dipendenti quello che si fa. Immagina quanto è antipatico che i dipendenti di un’azienda scoprano di iniziative di sostenibilità da LinkedIn! È come bypassarli, non prenderli in considerazione.
La comunicazione ha un “potere magico”: quello di ingaggiare le persone: le supporta, fa vedere quello che l’azienda sta facendo per la comunità. E ogni lavoratore non vive soltanto dentro l’azienda, ma anche fuori. Quindi il fatto di sapere che la tua azienda è impegnata e sta facendo delle cose e che, volendo, anche tu puoi portare suggerimenti, aiuto, supporto, idee, iniziative… è veramente qualcosa di magico.
ML: Quando parli di comunicazione interna, ti riferisci solo alla popolazione di dipendenti dell’azienda, o anche alle reti?
IS: Le prime persone che parlano all’esterno sono i colleghi, i dipendenti, che sono in tutto e per tutto gli ambasciatori dell’azienda.
Dopodiché, è importantissimo parlare con l’immediato esterno: coi clienti, con gli investitori, e con i fornitori che – con punti di vista diversi – possono essere essi stessi ingaggiati nei progetti di sostenibilità dell’azienda.
Per esempio, avere in attivo dei progetti di sostenibilità comunica agli investitori che l’azienda è solida, perché altrimenti sposterebbe quegli investimenti su altri fronti.
Un altro esempio: se comunicata bene, l’azione di sostenibilità dà un’idea precisa ai fornitori sul perché l’azienda inizia a fargli così tante domande. Quello che tutte le aziende fanno è inviare tantissimi questionari ai fornitori, e molto spesso il fornitore che lo riceve lo vive come un costo di tempo e di energia per rispondere. Per questo è importante ingaggiarli nel processo, spiegar loro quali sono i passaggi fondamentali che si stanno mettendo in atto.
In questo momento, per esempio, il tema dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori anche sul fronte della salute e sicurezza, è un tema molto caldo: tutte le aziende stanno inviando questionari su questionari ai loro fornitori per verificare come gestiscono non solo gli impatti del loro cantiere, ma anche sulle persone che vi lavorano.
Per questo anche la comunicazione esterna è importante, perché se un’azione di sostenibilità è portata avanti bene, è solo un vantaggio competitivo il fatto di comunicarlo.
Devi essere, ovviamente, forte di quello che fai e avere il pieno controllo di tutte le sfaccettature che esistono in un mondo in evoluzione, complesso e interconnesso!