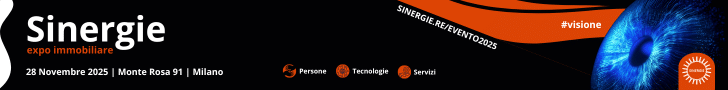Una lunga lingua verde si incunea verso il centro, nel nord di Milano.
Visto dall’alto sembra resistere ai grandi quartieri di grandi condomini costruiti dagli anni 60 in poi. Sembra farsi spazio e premere contro l’autostrada A4, la tangenziale Nord e le vie ad alto scorrimento.
Sembra insistere, con i suoi lunghi filari, i suoi boschi selvatici, i suoi laghi e le sue collinette, e dirci: “lo sapete che un’altra città è possibile?” Una città verde. In cui al centro c’è… lo spazio vuoto.
Non si tratta un’idea del futuro. Né figlia delle mode green di questo nostro contemporaneo.
No: stiamo parlando di un’idea del passato. Quella di fondare un parco nato là dove c’erano tutti gli interessi per continuare a costruire. Questa è la storia di Parco Nord Milano, raccontata da Riccardo Gini, direttore del Parco dal 2000, e direttore tecnico del progetto Forestami.
La storia di come una visione di 50 anni fa stia ispirando il nostro presente.
Domanda: Ciao Riccardo!
Partiamo subito da due domande semplici: chi sei e come arrivi a Parco Nord Milano?
Risposta: Sono innanzitutto un agronomo. Subito dopo la laurea, sono assunto da Montedison, nel settore Servizi Agricoltura. Stiamo parlando della fine degli anni 80, in Europa, un periodo in cui c’era una forte sovraproduzione agricola e si pagavano gli agricoltori affinché lasciassero a riposo i terreni. In quegli anni si lavorava all’applicazione di due regolamenti europei epocali, il Set-Aside e il Regolamento delle Zone Rurali. È stato un periodo importante, formativo, in cui ho girato tutto il paese, scoprendo con i miei occhi la varietà e la biodiversità delle nostre zone rurali.
La mia esperienza nel pubblico inizia come funzionario al comune di Milano. Dal dicembre 1994 al 2000 ho lavorato al settore Parchi e Giardini, occupandomi di pianificazione territoriale e gestione di verde pubblico. Nel 2000 viene indetto un concorso per il Direttore di Parco Nord, e lo vinco. Dal 1983, Parco Nord aveva avuto solo un direttore prima di me, ovvero Francesco Borella, con cui ho lavorato fianco a fianco per un anno, e che è venuto a mancare proprio in questi giorni con grande tristezza di tutti.
D: Ci racconti la storia di Parco Nord Milano?
R: Sono gli anni 60: immaginate le città che crescono a dismisura, senza alcuno strumento urbanistico.
Non c’è il PGT (Piano di Governo del Territorio, ndr), non c’è il PRG (Piano Regolatore Generale Comunale, ndr). L’unica intuizione che Milano ha è quella di creare il Piano Intercomunale Milanese, che prova a disegnare la grande città con questa intuizione: che in seno alla grande conurbazione che sta nascendo, potrebbe nascere un grande parco regionale, ovvero Parco Nord Milano.
Nel 1970, il prefetto conferma il disegno. La Ernesto Breda, che era proprietaria di tuti i terreni, abbassa i propri appetiti: prima del progetto Parco Nord Milano, c’era una grande spinta edilizia: lì volevano costruire centri commerciali e un quartiere da 50mila persone.
L’11 giugno del 1975, la Regione Lombardia, che è nata solo l’anno prima, riconosce Parco Nord Milano come Parco di livello regionale. Ma è una landa desolata. Se riguardate “La notte” di Antonioni, che è stata girata nei dintorni del Parco a quel tempo, vedrete che non c’è un albero, bensì capannoni, rottamatori, e campi: un “retrobottega della città costruita”.
Il primo presidente di questo Parco – Roberto Confalonieri – che allora non ha ancora 30 anni, decide di comprare i terreni – cioè di espropriare la Ernesto Breda dei primi 200 ettari dai quali sarebbe nato il Parco.
Ma i comuni, in un periodo in cui l’inflazione è particolarmente alta, si sono indebitati e non hanno più una lira. Il Parco rimane così in stand-by. Finché arriva il primo direttore Borella.
Lui ha un’intuizione: o si piantano alberi o questo Parco non nascerà mai. È il 1983 quando viene piantato il primo lotto di rimboschimento. Dal 1983 al 2025 non ci siamo più fermati e abbiamo fatto 42 lotti di rimboschimento: non è passato anno che Parco Nord non abbia continuato ad acquistare terreni e a piantarli.
Quando arrivo io, nel 2000, trovo una ventina di persone che lavorano al Parco che, allora, era stato realizzato per circa la metà rispetto al disegno originale. In pochi anni, dal 2000 al 2008 arriviamo ad essere 40, oltre ai diversi, fondamentali, volontari ben organizzati all’interno della cornice delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Dai 640 ettari iniziali, siamo arrivati a 960. All’interno ci sono zone che gestiamo a verde, e zone costruite di cui definiamo lo sviluppo urbanistico.
D: È solo un Parco, potrebbe dire qualcuno, ma che cos’è che lo rende così diverso dagli altri?
R: Le ricette sono due. Per prima cosa, c’è credibilità nell’azione: quando Parco Nord Milano interviene, è un ente affidabile.
E poi, condividiamo con i cittadini: c’è una direzione tecnica che sa quello che fa, ma i cittadini e le associazioni di quartiere sono sempre coinvolte.
Anzi, forse le ricette sono tre. L’ultima è stata fortemente voluta da me: è importante che il Parco faccia cultura. Il Parco non è solo un fatto ambientale, ma anche culturale. È un motore sociale e di sostenibilità.
Quando c’è uno spazio vuoto, da costruire, è difficile districarsi tra i desiderata di tutti: invece lo spazio vuoto è il cuore del Parco. Il suolo libero è la forza del Parco.
Questa piccola azienda pubblica che abbiamo creato ha un appeal anche per altri comuni che non sono nel circondario, ma che devono applicare il PNRR. Per esempio, Corsico, che ci ha chiamato per gestire cinque nuovi parchi nuovi.
Non solo con il pubblico, ma anche con il privato: con aziende che finalmente si sono rese sensibili sugli aspetti della sostenibilità e che ci aiutano a piantare, vengono a fare team building, o più semplicemente donano – come peraltro possono fare anche i cittadini.
D: Ci puoi dire qualcosa di più riguardo al rapporto tra sostenibilità, privati e Parco Nord?
R: Noi abbiamo un catalogo che prevede diverse attività che le aziende possono fare nel Parco. Per esempio, le attività di team-building. Sono attività manuali e pratiche, come la piantagione di nuovi boschi, la pulizia delle aree del Parco, oppure visite guidate per dipendenti, attività negli orti.
Sugli aspetti legati agli ESG, invece, proponiamo alle aziende di essere contributori delle nuove piantagioni e/o delle attività che facciamo, sostenendoci economicamente e costituendosi come partner che aiutano a sviluppare questo luogo e a renderlo più bello.
Nel 2015, il Parco si è allargato da 640 ettari a circa 800 perché ha incorporato 150 ettari di una zona agricola che si chiama “Parco della Balossa”, tra Novate e Cormano. Per quest’area abbiamo lanciato una campagna che si chiama “Insieme per la terra”, che mira a trasformare un fabbricato, chiamato Hangar Balossa, in un nuovo centro di Arte e Terra, in cui artiste e artisti possano esprimersi attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. Questa è un’altra delle chiamate della corresponsabilità delle aziende, che vogliono applicare l’ESG: non solo a livello ambientale, ma anche sociale e artistico.
Possiamo rispondere alle esigenze di tanti tipi di aziende, dalla piccola che vuole contribuire o portare i suoi dipendenti nel Parco, a quelle grandi, che possono anche arrivare a prendere in co-gestione degli spazi, affinché li trasformino in servizi per la comunità: strutture ricettive, ostelli, bar, ristoranti, co-working e così via.
D: Sono state più le aziende a chiedere o voi avete creato una domanda?
R: Sono state più le aziende. Cinque anni fa abbiamo introdotto nel nostro organico una figura che si interfacciasse e che si prendesse cura di queste esigenze. Siamo comunque sempre concentrati sul completare e mantenere il Parco, ma il sostegno di queste realtà è vitale.
Parliamo del progetto “Forestami”: in una Milano che continua a costruire, la sfida di questa iniziativa – il cui slogan è “3 milioni di alberi piantati entro il 2030” – è affascinante e controcorrente.
“Forestami” è nato con questo slogan, ma in realtà il nostro obiettivo è aumentare la copertura arborea del 5%, e di mantenere il verde che viene piantato e che c’è già, perché è inutile piantare se poi non ci sono le risorse per irrigare e curare.
Sembrano tanti? Ebbene, nel 2018 uno studio di rilevamento satellitare fatto dal Politecnico ha evidenziato che nel territorio si sarebbero potuti piantare 5 milioni di alberi. Siamo in contatto con i 133 comuni della Città Metropolitana, comune per comune, e abbiamo siglato, con questi, 70 protocolli d’impresa e di adesione al progetto (altri 18 dovrebbero arrivare entro l’anno). In questi protocolli condividiamo le finalità e “ci mettiamo gli occhiali verdi”, ovvero vediamo quali sono le potenzialità di incremento del capitale naturale che il territorio di ciascun comune ha, che non sia già destinato all’edilizia. Questo ci consente di avere una mappa di aree potenzialmente piantabili. Vorremmo che “Forestami” non sia solo uno slogan, ma anche un modo per far conoscere ai cittadini e alle cittadine la Natura che li circonda in città.
D: Hai usato una bellissima espressione: “capitale naturale”. Come la tradurresti?
R: Se vogliamo essere banali, quando parliamo di “capitale naturale”, indichiamo alberi, arbusti e così via.
Ma perché lo chiamiamo “capitale”? Perché ha un grande valore!
Il capitale naturale ha un valore incrementale, perché nel contrasto dei cambiamenti climatici, nell’assorbimento della CO2, nel drenaggio dei suoli, nel raffrescamento delle aree urbane, il capitale naturale continua a crescere e produrre benefici.
Pensateci: un albero, alla sua messa a dimora, sarà alto sì e no un metro. Tuttavia, quando questo crescerà le sue capacità di miglioramento del territorio che lo circonda diventeranno esponenziali.
È un investimento molto conveniente perché piantare un arbusto costa poco, circa 40 euro, ma ciò che rende nel tempo, nel suo sviluppo, è tantissimo in termini di qualità della vita, dell’aria, del suolo.
D: Che cosa desideri che le persone imparino dalla Natura?
R: Dalla Natura si deve imparare la pazienza. Le piante hanno il loro tempo di crescita, il loro tempo di risposta.
Come seconda cosa, dobbiamo imparare che la Natura non è soltanto quella idilliaca, bucolica, delle Georgiche di Virgilio. È una Natura che non dobbiamo addomesticare, perché ciò che è selvatico ha la sua ragione di esistere.
Pochi giorni fa, per i 50 anni del Parco, abbiamo fatto sottoscrivere un patto ai sindaci dei comuni della Città Metropolitana, “come immaginiamo il Parco nel 2075?”
Lo immaginiamo come un luogo diverso dalla città, che ha altre regole e tempi rispetto all’urbanizzato. Un luogo dove cittadine e cittadini possano imparare a rispettare la Natura affinché portino questa nuova consapevolezza anche una volta usciti dal Parco.
Vorremmo che anche le aziende capissero questo: che le logiche del profitto possono coesistere all’interno di un ecosistema in cui il costruito sia sostenibile.
Per fare questo è importante che la Natura sia maggiormente conosciuta e riconosciuta: la maggior parte di noi sa citare almeno dieci marchi di automobili, ma quanti saprebbero riconoscere dieci specie arboree? C’è un ciclo della Natura che non corrisponde per forza a quello umano: e che un parco come il Parco Nord Milano ha bisogno, per esempio, di essere buio, di notte, per preservare le esigenze della fauna notturna. Non c’è, quindi, un tema di delinquenza o poca sicurezza, perché il crimine non si sviluppa nel buio, o nel bosco, ma nella penombra dei lampioni, nelle vie cittadine.
A tal proposito, negli ultimi anni sembra cambiato davvero molto il percepito sul Parco. Ora è davvero frequentato e vissuto: un luogo dentro Milano, ma lontano dalla città. Anche tu, dopo così tanti anni, ti senti cambiato?
Dopo 25 anni, mi emoziono ancora: è davvero entusiasmante lavorare tutti i giorni in un luogo simile. Questo lavoro riconnette non solo alla Natura, ma anche a sé stessi.