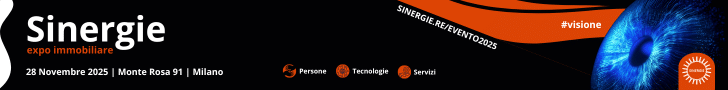Dal rapporto Cisf, Centro internazionale studi famiglia 2024 era emerso che il 52,3% delle persone che avevano acquistato casa aveva ricevuto, in tutto o in parte, un sostegno all’acquisto da parte dei genitori o di altri familiari, percentuale che superava il 70% nella fascia d’età under 35. Circa la metà di questi aveva ricevuto una donazione, per il 21,3% si era trattato di un anticipo sull’eredità e per il 19,3% di un prestito.
Se la casa è un diritto, per i giovani questo era, ed è tuttora, supportato dai familiari.
I dati sono noti: secondo l’analisi l’Omi, la forbice tra la domanda e l’offerta di abitazioni accessibili si è ampliata. Il prezzo medio di una casa di dimensione modesta in città come Milano o Roma può superare i 4.000 euro al metro quadrato, ma il reddito annuo di un giovane lavoratore spesso si aggira attorno ai 20-25.000 euro, con punte più basse al sud e nelle regioni meno industrializzate.
Si può quindi parlare di esclusione abitativa per i giovani, tanto che l’Istat stima che il 40% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni vive ancora in famiglia, un dato che va oltre i motivi culturali e tocca le difficoltà economiche nel raggiungere l’autonomia abitativa.
Inoltre, i prezzi degli immobili continuano a crescere: si parla di un +4% nel primo semestre del 2025, che fa scivolare ancora di più il rapporto tra il costo della casa e il reddito disponibile dei giovani lavoratori.
Sebbene con l’allentamento del costo del denaro da parte della Bce i tassi siano scesi e, per la prima volta, a ottobre 2025, il variabile sia più conveniente del fisso, in Italia, a luglio 2025, il tasso medio era del 3,19%, leggermente sotto la media dell’area euro (3,28%), ma più alto che in Spagna, Finlandia, Croazia, Francia e Portogallo.
In Paesi come Germania, Irlanda, Belgio e Austria, il mutuo costa di più, ma i salari medi sono più alti e il mercato del lavoro è più stabile. Stesso discorso per i paesi del Nord Europa, dove retribuzioni più solide permettono alle banche di concedere mutui a costi più favorevoli, anche se i tassi sono più elevati.
La stessa Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, ha dichiarato che stipendi bassi e contratti a termine sempre più diffusi spingono le banche a chiedere maggiori garanzie e imporre condizioni meno vantaggiose. Garanzie che, ritornando all’inizio, creano quel cortocircuito per cui i giovani devono chiedere un aiuto economico ai familiari per potersi permettere l’acquisto di una casa.
Attualmente è in vigore l’agevolazione per l’acquisto della prima casa under 36, dedicata alle persone che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui è stipulato l’atto e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro. È prevista l’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la prima casa (escluse quelle di pregio) e per gli atti traslativi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alla stessa.
Vi è quindi la possibilità di accedere al Fondo di garanzia dei mutui prima casa, misura prorogata fino al 2027, che rappresenta una boccata d’ossigeno per i giovani che vogliono acquistare casa.
Il punto è capire per quanto tempo e con quali sforzi questa situazione potrà andare avanti. I mutui costano meno, ma gli stipendi non sono ancora adeguati al costo delle case, che sale di anno in anno. Le alternative living, come ad esempio il cohousing, ci sono ma scarseggiano e sono attive soprattutto nelle grandi città, dove si concentra l’attenzione degli sviluppatori.
La maggioranza dei giovani si troverà quindi a districarsi tra costi al metro quadro che aumentano e necessità di chiedere supporto, che sia allo stato o alla famiglia, una situazione che cambia status alla casa e la fa slittare da diritto a privilegio.