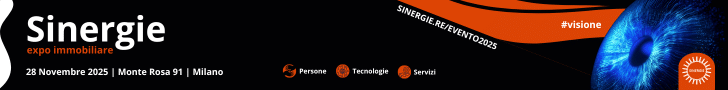In Europa, il provision rate, ovvero il numero di posti letto sul totale degli studenti fuori sede, è di circa il 20%. Se si considera il numero di studenti fuori sede in Italia, che supera le 600.000 persone, significa che per equipararsi alla media europea l’offerta nostrana dovrebbe essere di almeno 120.000 posti letto dedicati. Eppure, a maggio 2025, l’Italia conta uno stock di 20.000 posti letto già operativi e una pipeline di altri 20.000 posti letto disponibili da qui al 2027.
Questo, da un lato, mostra che i privati stanno guardando allo student housing con investimenti (4 miliardi di euro stimati), trainati principalmente da investitori istituzionali e casse come Cdp.
Ma sebbene i numeri siano rilevanti, resta il fatto che in Italia lo student housing potrà arrivare a coprire da qui a due anni solo il 6-7% della platea di studenti fuori sede.
Questo è quanto emerge dall’analisi “Una casa per studiare: lo student housing” secondo l’Osservatorio di Confindustria Assoimmobiliare, che ha dedicato un quaderno frutto di studi di due anni di studi sul settore.
Il quaderno pone l’accento sui nuovi modelli gestionali: il settore dello student housing si sta evolvendo verso modelli più flessibili, più ibridi e più contemporanei.
Si può iniziare dal modello del campus studentesco, che arriva dai Paesi anglosassoni e che si sta diffondendo in Italia, strutture concepite come microcosmi dove l’abitare si integra con i servizi accademici, ma anche culturali, ricreativi e sportivi.
L’obiettivo, in questo caso, non è solo fornire un alloggio, ma costruire un ambiente che possa accompagnare lo studente nel percorso di formazione, crescita e socializzazione. Una struttura autosufficiente che, dal punto di vista della gestione, è definita da una programmazione di lungo periodo, poiché la pianificazione delle iscrizioni universitarie e la concentrazione di altre attività nelle aree urbane garantiscono tassi di occupancy stabili e prevedibili. Naturalmente, il modello campus richiede investimenti iniziali più consistenti, ma con solide redditività nel lungo periodo.
Invece, il modello di cohousing, che prevede la condivisione di spazi abitativi per piccoli gruppi di studenti in appartamenti, rappresenta una formula intermedia tra la residenza tradizionale e il campus diffuso.
Dal lato dell’investitore, è una soluzione flessibile e sicuramente scalabile, perché gli appartamenti possono essere sviluppati in edifici ex novo oppure ricavati dalla riconversione di immobili esistenti. Hanno un tasso di occupazione elevato e resilienza, anche perché hanno un prezzo competitivo rispetto alle soluzioni individuali e intercettano la fascia di studenti più ampia e sensibile ai costi. Inoltre, la struttura dei ricavi tende a essere più stabile, poiché si basa su contratti plurimi nello stesso appartamento, fattore che mitiga il rischio di vacanze totali e diversifica l’esposizione per l’operatore.
Il modello ibrido, quindi, nasce per superare le rigidità degli asset tradizionali, combinando in un’unica struttura short housing, short stay, hotel, co-working e community services. Il modello è rivolto a una popolazione giovane e internazionale, e l’offerta unisce soluzioni abitative full optional con spazi condivisi e contenuti esperienziali: coworking, eventi, palestre, attività culturali e networking.
Un’alternativa alla locazione più classica
In Italia la quota di investimenti residenziali sul totale del commercial real estate resta limitata rispetto ad altri Paesi europei: solo l’8% nel 2024, contro il 25% della Germania, il 23% della Francia e il 30% della Spagna. I modelli di living, come multi-family, senior living e micro-living, tra cui lo student housing, stanno cercando di interpretare i bisogni residenziali e di rappresentare un’alternativa al costo elevato della locazione in Italia.
Lo student housing, secondo Assoimmobiliare, è uno dei segmenti residenziali più maturi, perché sta attirando un numero crescente di investitori, dato che l’offerta è disallineata rispetto alla popolazione studentesca. Si tratta di 83.000 posti a livello nazionale, con un provision rate, ovvero la percentuale di posti letto disponibili rispetto al numero totale di iscritti, di circa il 5%, uno dei più bassi d’Europa. In Francia è del 16%, in Germania del 13% e nel Regno Unito, storicamente votato allo student housing, del 30%.
Dal punto di vista dell’offerta, il 70% dei posti disponibili è pubblico e il restante 30% è gestito da operatori professionali (Pbsa). In Italia ci sono 99 università (di cui 15 telematiche), a cui si aggiungono 165 istituzioni di alta formazione artistica, museale e coreutica riconosciute dal Ministero. Roma svetta come principale città universitaria del Paese, sia per numero di sedi che per popolazione studentesca. Le prime sette città italiane sono Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Padova e Firenze. La quota di fuori sede in Italia è di 700.000 persone, pari a oltre il 40% degli iscritti ai percorsi universitari.
Il settore immobiliare prevede una quota di fuori sede per città: Milano conta circa 92.000 studenti fuori sede (48% del totale degli iscritti), Roma il 35%, Torino il 40%, Bologna il 65%, seguite da Padova, Pisa, Napoli e Firenze.
L’Osservatorio Assoimmobiliare ha raccolto informazioni su circa 19.500 posti letto distribuiti in 80 strutture in 20 città universitarie. Milano è il mercato più maturo, con oltre 6.000 posti letto, pari al 31% del totale, seguita da Torino (13%), Bologna e Roma (entrambe 12%) e Firenze (11%).
La pipeline conta 20.000 nuove unità al 2027, distribuite in 61 progetti. La maggior parte dei nuovi sviluppi sarà concentrata nelle principali città universitarie: Milano da sola accoglierà il 34% dell’offerta, seguita da Roma con il 10% e poi in crescita città come Padova, Firenze e Pavia. Torino e Bologna mostrano invece una pipeline scarsa, con un incremento inferiore al 4%.
Alla luce di questi dati, la distribuzione della copertura resterà eterogenea: Milano, che oggi conta circa 92.000 iscritti fuori sede e una copertura effettiva pari al 6,9%, con i nuovi sviluppi potrà arrivare intorno al 13%.
Roma, con circa 70.000 studenti fuori sede, pur beneficiando di una pipeline significativa, resterà attorno a una copertura del 6% (dagli attuali 5,5%). A Torino, dove gli studenti fuori sede sono circa 45.000, la copertura passerà dall’attuale 8,5% a oltre il 10% nel 2027. Bologna, che ospita la quota più elevata di fuori sede in Italia (44.000, pari al 65% degli iscritti), parte invece da un livello di copertura molto basso (5%), che solo marginalmente salirà sopra il 6% entro il 2027
Dal quadro, considerando anche la pipeline al 2027, emerge quindi un bisogno strutturale di posti letto insoddisfatto. Tra le cause, Assoimmobiliare individua anche l’assenza di una disciplina organica a livello statale e un conseguente quadro regolamentare frammentato, in cui regioni e comuni applicano procedimenti, categorie urbanistiche e definizioni difformi. Il gap è significativo, se confrontato con altre giurisdizioni come Germania e Francia, dove le politiche nazionali sono coordinate e i quadri normativi chiari. Gli investitori lamentano, in particolare, i tempi autorizzativi lunghi (18-24 mesi contro 6-12 mesi in altri Paesi dell’Unione Europea), l’incertezza sulla classificazione urbanistica e la complessità del coordinamento tra normativa nazionale e locale.
Assoimmobiliare ha quindi evidenziato come, in mancanza di una categoria urbanistica unitaria, gli studentati privati vengano ricondotti, secondo valutazioni caso per caso, a destinazioni d’uso già esistenti che possono variare tra residenziale, turistico-ricettiva o servizi, sulla base delle caratteristiche edilizie e funzionali dell’intervento e delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.
Emerge quindi il quadro di un settore dall’elevatissimo potenziale di sviluppo, ma condizionato dalla complessità delle norme locali.
Cosa propone Assoimmobiliare per lo sviluppo del settore? Introdurre procedure autorizzative unificate e semplificate di fast track per realizzare studentati con un procedimento unico, che abbia termini certi per l’ottenimento dei titoli abitativi, e il riconoscimento per lo student housing di una funzione urbanistica autonoma, distinta dal residenziale ordinario e dal turistico-ricettivo. Inoltre, propone l’estensione e la stabilizzazione del regime Pnrr, rendendo permanenti e strutturali per tutti gli studentati le misure previste per l’edilizia residenziale sociale, come il cambio di destinazione d’uso sempre consentito per le residenze universitarie.
Infine, una riforma della legge 338/2000 con l’introduzione di agevolazioni strutturali a fronte dell’impegno da parte degli operatori, anche privati, a mantenere politiche tariffarie calmierate rispetto al mercato. I contributi pubblici dovrebbero sostenere non solo gli investimenti ma anche la gestione, con azzeramento o riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei contributi al costo di costruzione, come avviene già in alcuni comuni virtuosi.
Servono inoltre incentivi per la decarbonizzazione e l’efficientamento energetico degli edifici, agevolazioni fiscali a livello nazionale e locale, e una disciplina favorevole alla riconversione degli immobili in altre funzioni all’esaurirsi della destinazione studentesca (ad esempio, residenziale o ricettiva), con possibilità di usi misti parziali, così da superare la rigidità degli asset tradizionali e rispondere alla flessibilità della domanda, che si prevede sempre più in crescita negli anni a venire.