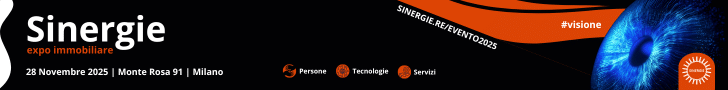Per misurare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano si può partire dagli Ape, gli attestati di prestazione energetica. A fine 2024 sono 6 milioni quelli contati dal Siape (Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica), che coprono un arco di tempo che va dal 2015 a fine 2024. Solo nel 2024 ne sono stati emessi 1,2 milioni, +8%, che evidenziano una distribuzione per destinazione d’uso che rimane stabile rispetto al 2023: l’87,5% riguarda edifici residenziali, mentre il restante 12,5% si riferisce al comparto non residenziale.
I risultati parlano di un parco immobiliare poco efficiente, dove le classi energetiche A4-B rappresentano quasi il 20% degli attestati (in lieve calo rispetto al 20,8% del 2023), mentre le classi energetiche C-E sono aumentate di oltre due punti percentuali. Le classi energetiche F e G, pur restando prevalenti, sono scese sotto il 44%, segnalando un lento ma costante processo di transizione verso edifici più efficienti.
Dal confronto per destinazione d’uso sono invece emerse differenze più marcate rispetto al 2023: sono migliorate le abitazioni a carattere non continuativo e gli immobili adibiti a usi sanitari, mentre tutte le destinazioni d’uso del settore non residenziale hanno mostrato una percentuale delle classi energetiche F-G tra il 40% e il 10%, con l’esclusione delle attività industriali, dove la percentuale si è attestata attorno al 60%.
Enea ha quindi sottolineato che nel 2024 il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza è stato pari a 4,5 Mtep/anno, dove Mtep (tonnellata equivalente di petrolio) è la misura che confronta l’energia di diverse fonti con quella liberata dalla combustione di un milione di tonnellate di greggio.
In sostanza, si tratta di un quantitativo equivalente all’energia necessaria ad alimentare oltre 4 milioni di abitazioni. Il dato corrisponde al 90% dell’obiettivo intermedio fissato dal Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, a 5,04 Mtep per le misure monitorate.
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso meccanismi di detrazione fiscale che hanno generato risparmi energetici pari a circa 2,48 Mtep: certificati bianchi, risparmi incentivati grazie al conto termico, misure di mobilità sostenibile e fondi di coesione.
Un risultato che è stato definito incoraggiante, come aveva commentato la presidente Enea Francesca Mariotti: “In un contesto di sfide sistemiche senza precedenti, il Rapporto segnala progressi incoraggianti sul fronte dell’efficienza energetica, con miglioramenti rilevanti nel settore residenziale e nelle imprese”.
La transizione energetica va a braccetto con la rigenerazione urbana e, secondo le stime elaborate da Thea, il mercato potenziale del comparto potrebbe sbloccare 1.360 miliardi di euro. L’impatto complessivo sul Pil (diretto, indiretto e indotto) è stimato in quasi 1.600 miliardi di euro nel periodo tra il 2025 e il 2050. Nei prossimi 25 anni, la filiera sarà impegnata a rigenerare circa 320 milioni di metri quadrati di superficie lorda distribuiti sul territorio.
Thea pone l’accento sull’economia reale e individua le difficoltà a generare investimenti in logiche ancora limitate alla dimensione economico-finanziaria, in un impianto normativo considerato inadeguato e in un’interazione non ottimale tra settore privato e Pubblica Amministrazione, oltre che nella bassa redditività riscontrata nella maggior parte dei territori.
Il residenziale è poco efficiente
Guardando le transazioni immobiliari relative all’anno 2024, rispetto alla tipologia edilizia e alla classe energetica, le ultime classi per performance energetica sono ancora la netta maggioranza (dal 72% di edifici nelle classi E, F e G per i monolocali a un 63% delle villette a schiera, dato stabile rispetto al 2023).
I dati arrivano dall’analisi Enea, I-Com e Fiaip, secondo cui sono aumentate le transazioni immobiliari per edifici in classe E per trilocali, villette a schiera e ville unifamiliari (rispettivamente +14%, +20% e +23%), seppur quelle di immobili in classe G siano diminuite per villette a schiera e ville monofamiliari (-12% e -23% rispettivamente).
C’è ancora polarizzazione della distribuzione per classi energetiche rispetto all’ubicazione dell’immobile: in periferia gli immobili compravenduti sono per l’85% nelle classi energetiche meno performanti (E, F e G) e la quota degli edifici più performanti (A e B) non raggiunge il 5%; nelle zone di pregio la percentuale di immobili nelle prime classi energetiche (A e B) è al 46%.
Inoltre, c’è disomogeneità di percezione tra acquirenti e venditori sulla qualità energetica degli immobili: il 69% degli acquirenti dimostra una consapevolezza almeno sufficiente del valore dell’efficienza energetica (in crescita rispetto al 62% rilevato nel 2023), mentre tra i venditori tale percentuale si attesta al 55%, in netto miglioramento rispetto al 42% dell’anno precedente.
Anche se leggermente diversi, i dati sono comunque quelli: il patrimonio residenziale italiano è scarsamente efficiente. Secondo il rapporto Nomisma-Rockwool, aggiornato a maggio 2024, il 54% delle abitazioni italiane appartiene alle classi energetiche con le performance peggiori (classi F e G). In particolare, nella zona climatica D la percentuale di abitazioni con le prestazioni peggiori raggiunge il 65%, incidendo fortemente sui consumi energetici del settore residenziale.
Secondo l’analisi, oltre la metà dell’obiettivo fissato dalla direttiva (l’8% su 16%) è già stato conseguito grazie agli interventi di riqualificazione energetica favoriti dagli incentivi fiscali messi in atto dal 2020 al 2023 (Superbonus 110%, Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Facciate). Questi interventi hanno consentito infatti di ottenere un 8,9% di risparmio energetico e rimane pertanto da conseguire un ulteriore risparmio del 7,1% dei consumi energetici entro il 2030, per cui servirebbero 83,4 miliardi di euro in interventi di riqualificazione.
Ma la stima delle case da efficientare, in termini di immobili interessati dalla normativa Case Green, è di 4 milioni e il nodo per il residenziale è nell’economia delle famiglie. Senza incentivi e aiuti statali, infatti, non c’è partita, visti i costi importanti delle ristrutturazioni e gli stipendi medi italiani.
Buone notizie dal Conto termico 3.0
Da poco pubblicato in Gazzetta, il Conto Termico 3.0 permette di ricevere un contributo economico a fondo perduto che copre fino al 65% delle spese sostenute per efficientare, che raggiungono il 100% per gli edifici pubblici situati in piccoli comuni. L’incentivo riguarda tutti gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche o sostituiscono impianti obsoleti.
Entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 e il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente entro 60 giorni, oppure suddiviso in rate qualora l’importo superi i 15.000 euro.
Sono finanziabili numerosi interventi, quali ad esempio la coibentazione di pareti e coperture, la sostituzione di caldaie con pompe di calore, l’installazione di collettori solari termici, fotovoltaici e impianti ibridi, le colonnine di ricarica per auto elettriche se incluse in un progetto di riqualificazione.
Il governo ha stanziato 900 milioni di euro (400 per la Pa) e possono richiedere il Conto termico 3.0 le pubbliche amministrazioni, anche per edifici scolastici o sanitari, i privati cittadini e i condomini, ma solo per interventi che utilizzano fonti rinnovabili e non per lavori di isolamento, oltre alle imprese e agli enti del terzo settore con alcune specifiche.
Le novità rispetto al Conto Termico 2.0 riguardano un iter più semplice e digitalizzato, che sarà gestito attraverso un portale dedicato, l’ammissione anche degli edifici a energia quasi zero e degli interventi con ampliamento fino al 25%, l’introduzione di nuove tecnologie come i sistemi di accumulo e il fotovoltaico integrato e il raddoppio del budget per la Pa con incentivi fino al 100% per gli edifici pubblici nei piccoli comuni.
Questo incentivo apre quindi uno spiraglio per l’efficientamento del parco immobiliare, mentre a livello complessivo di rigenerazione servono probabilmente interventi più massicci. La proposta di Thea guarda a forme di partenariato pubblico-privato che integrino la dimensione del valore per i territori, anche tramite la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Il percorso verso l’efficientamento del parco immobiliare italiano è quindi avviato ma gli ostacoli sono robusti e, per superarli, serve una visione politica chiara e che, soprattutto, abbia molto a cuore questo argomento.